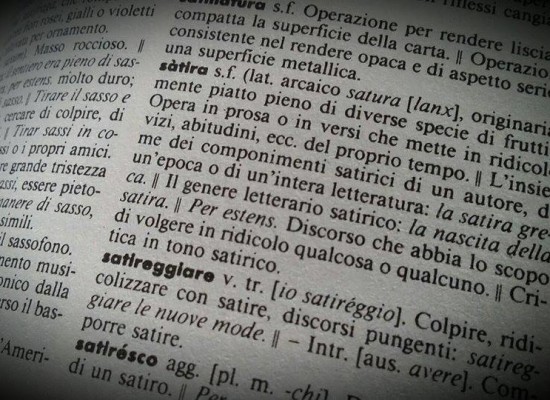E’ stato l’altro giorno.
Saranno state le undici, al massimo mezzogiorno.
E’ stato più o meno a quell’ora, che ho incontrato Berlinguer.
Enrico Berlinguer.
Stavo lì, ad abbronzarmi sotto i faretti alogeni del nuovo mercato centrale in attesa del mio turno, quando un signore dalla corporatura esile, il volto sorridente e l’aria trasognata mi ha lievemente urtato, carico di sacchetti di carta e plastica contenenti la spesa del giorno.
Era un uomo distinto, il viso solcato da una malinconia dolce e sfuggente come quel lembo di cravatta che gli divideva il torace in due metà perfette tanto da renderle quasi autonome, come due Granducati, due provincie amministrate rispettivamente da Polmone Destro e Polmone Sinistro.
Era Berlinguer.
Berlinguer che scompariva rapido, inghiottito dalla folla indifferente e rumorosa del mercato.
Berlinguer.
Quello del Partito Comunista.
Berlinguer, il sassarese che arrivò lontano.
Come molti altri, certo.
Ma anche no.
Berlinguer, il politico gentile. Quello che ha unito milioni di italiani sotto un sogno comune. Quello che quando ha deciso di andarsene, durante un comizio in quella Padova bella e dannata, ha lasciato una ferita che non si è mai più rimarginata nel panorama politico di questo nostro Paese. Sangue che si è riversato sulle strade di quella Roma triste nel giorno del suo ultimo saluto, sotto forma di volti, mani, voci, persone.
Perché in fondo è bello, anzi bellissimo e anche parecchio poetico credere che il sangue del partito del Popolo sia il Popolo stesso. Quel popolo che quel giorno piangeva, e cantava, e chiamava a gran voce il suo nome. Come se niente fosse mai successo. Come se lui fosse ancora lì.
Berlinguer se n’era andato. E con lui se ne sarebbe andata pian piano un’intera generazione che in quella sua esile figura aveva visto una speranza, una guida, un amico. Tutto questo accadeva nel 1984. Trenta anni fa.
Solo che io Berlinguer l’ho visto.
Ieri.
Nel duemilaquattordici.
Al mercato.
E non era uno che gli assomigliava, nemmeno si trattava di un brutto scherzo della mia immaginazione.
Era proprio lui; perché se è vero che le anime dei defunti amano tornare in visita nei luoghi della propria vita, non vedo perché anche per Berlinguer non debba essere così.
Certo un comunista che si rispetti non dovrebbe credere a simili scempiaggini spirituali sull’anima, sulla reincarnazione o su tutto ciò che abbia a che fare con la vita ultraterrena; dovrebbe mantenersi ancorato alla realtà mediante una visione pratica, inattaccabile e che risulti, a qualunque costo, razionale; ma se l’ “anima” altro non fosse che una proiezione post-mortem dei sogni che abbiamo fatto in vita?
Voglio dire, Berlinguer era lì. Mi è passato davanti. Mi ha toccato, mi ha guardato negli occhi, come per scusarsi. Come per volermi dire: << Questo sono io. Enrico Berlinguer. E sono qui, in vacanza premio per tutti i sogni per i quali ho lottato. Mi hanno concesso un altro po’ di tempo fra voi; non per buona condotta o per strane raccomandazioni, ma per i sogni avuti. Per quanto ho amato i sogni e inseguito senza sosta la strada della loro realizzazione. Per quanto ho sognato in vita mia>>.
Ho provato a seguirlo, Enrico, almeno con lo sguardo; e una volta tornato a casa, ho provato ad immaginarmi il suo itinerario in quella sua Sassari; i suoi passi leggeri nei vicoli del centro storico, verso l’ora di pranzo, quando l’aria si impregna di odori di arrosto, minestrone e spezie, a contrastare la fragranza prepotente della strada che sa di muffa, terra bagnata e pipì di gatto; l’ho visto passare in quelle piazze semichiuse e quasi senza nome, in mezzo a bambini che giocano a pallone e case con la porta socchiusa in cui guardare dentro con discrezione; l’ho visto osservare con diffidenza certi obbrobri architettonici, e le file di macchine in perenne processione alla ricerca di un parcheggio, e i cartelli contro la ZTL, e le sale slot piene di poveri diavoli che inseguono il sogno sbagliato perché non c’è rimasto più nessuno a spacciare i sogni giusti, nemmeno per uso personale.
Lo vedo passare di fronte al Liceo Azuni, la sua scuola, proprio nel momento esatto in cui una studentessa intervistata da un reporter del tg regionale, alla domanda <<Chi era Berlinguer?>> non sa rispondere, e cela l’imbarazzo dietro ad una risata a bassa voce, quasi sussurrata.
Lo immagino sorridere a sua volta e risalire verso Piazza d’Italia, affrontando la salita di via Carlo Alberto col sorriso, dei versi di Gozzano ripetuti nella testa come un mantra:
<<Mio cuore
monello giocondo che
ride pur anco nel pianto
mio cuore bambino
che è tanto
felice d’esistere
al mondo>>.
Così me lo vedo, Enrico di ritorno nella sua Sassari. Come un bambino felice che riscopre per caso, sotto una qualche vecchia credenza, un gioco che credeva perduto.
Facendo qualche passo verso Piazza Castello si accorge che al Teatro Verdi proiettano un film su di lui; la regia è di un certo Veltroni. Il nome però gli dice poco o nulla e oltretutto la giornata è troppo bella, troppo piena di sole per passarla rinchiusi al buio di una sala; molto meglio concedersi un buon bicchiere di vino, magari all’aperto, ascoltando quello che ti accade intorno; magari all’ombra di quel Duomo, rimasto uguale a come anche lui lo ricordava, splendida testimonianza di come la vera bellezza sia inattaccabile dai cambiamenti del tempo.
Enrico vede passeggiare davanti a se la gente che anima la piazza; una moltitudine di donne, uomini e bambini che sfila secondo un ordine complesso e preciso, regolato da leggi ignote, sotto quel sole di Sardegna onesto e verace.
Ad Enrico la gente era sempre piaciuta.
Con i suoi pregi, i suoi difetti.
Amava le debolezze di ognuno. Era riuscito a trasformare le proprie in segni distintivi, forti e netti, che lo hanno reso ciò che è stato.
Il suo vino è finito; “lo offre la casa”, si affretta a dire il barista. Basta un sorriso dei suoi, per ringraziarlo nel migliore dei modi possibili.
Il sole sta diventando più caldo; Enrico prende la sua spesa, attraversa piazza Duomo. La sua ombra si riflette in diagonale, esile e affusolata come un giunco, fino a sparire abbracciata dall’oscurità del prossimo vicolo.
I palazzi ravvicinati sembrano consumare un amplesso che va avanti da secoli.
Ad Enrico lo aspettano un pranzo frugale e una sana pennichella, da farsi senza sensi di colpa.
D’altronde questa è una legge vecchia come il mondo: bisogna riposare, per poter sognare.
Michèl Merini